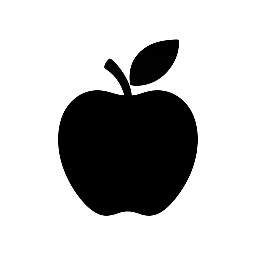Dieci aprile duemilauno, da questa data si dipanano i dubbi e le incertezze sul percorso che avrebbe portato l’olio extravergine di oliva dall’essere considerato un prodotto di consumo a divenire un valore sociale, un riferimento culturale della qualità e un presidio salutistico dalle mille virtù.
Gli Evo appassionati conoscono bene l’incipit del Manifesto in progress di Luigi Veronelli donato al mondo venticinque anni fa: “Ciascuno avverte. È in corso un epocale mutamento sociale. Coinvolge appieno l’agricoltura. Il divenire, per certi aspetti rivoluzionario, del comparto olio d’oliva è già iniziato”.

Queste parole tracciano un solco temporale tra due culture produttive e avviano un processo irreversibile che offrirà due visioni del mondo produttivo olivicolo: quello dell’illusione della conservazione e quello della ragione della tradizione. In questo articolo, le cui riflessioni si rivolgono agli ultimi vent’anni di produzione olivicola, proverò a offrire alcuni stimoli su queste visioni indicate.
L’Illusione della conservazione
Il progresso, in qualsiasi disciplina, nasce dall’urgenza di guardare oltre il noto e comprendere le modalità più funzionali per ampliare il proprio agire in relazione alle intuizioni che permeano qualsiasi atto creativo.
La conservazione è la negazione dell’atto generativo. La frase tipica del “si è fatto sempre così” e di “un tempo era meglio”, rappresentano pensieri e conseguenti azioni in grado di ostacolare l’avvento di nuovi processi produttivi tesi alla valorizzazione del potenziale del nuovo agire costituito da pratiche innovative.
L’illusione considera il passato come il luogo delle risposte, considera efficace il pensiero lineare diffida dell’apprendimento come strategia di sviluppo.
Tuttavia, la storia dell’olivicoltura è ricca di strade dense di conoscenze che non hanno seguito itinerari lineari ed unidirezionali. In ogni segmento temporale sono presenti intuizioni, errori, prassi innovative e contraddizioni, miti e credenze.
Transitato tra queste strade Columella, agronomo e artista della terra, vissuto nel primo secolo dopo Cristo aveva intuito e sperimentato le linee di maturazione delle drupe e ne aveva classificato il processo qualitativo tanto da attribuire a solo due momenti il tempo giusto per la raccolta e la spremitura: Oleum ex Albis ulivis (ottenuto da olive verdi) e Oleum viride (da olive verdi nella prima fase di invaiatura).
Quelle indicazioni sono ancora oggi il patrimonio basilare delle nostre produzioni di eccellenza.
Tuttavia, nel corso dei secoli hanno prevalso logiche di produzione quantitative, anche comprendibili considerando i bisogni e i fabbisogni delle varie epoche.
L’olio, come sappiamo, era considerato e utilizzato nelle comunità produttive locali per la struttura grassa, la natura conservativa, come condimento e la cottura dei cibi e, marginalmente, per un uso estetico, saponi e unguenti; quasi sempre era associato all’olio un carattere simbolico e religioso.
Era ben identificata la pratica di raccolta delle olive centrata sullo stato di maturazione avanzata. Poco interesse suscitavano le intuizioni sull’anticipo della raccolta e il processo di molitura era quasi sempre affidato a terzi. Questa pratica ha determinano un gusto culturale identitario di forte matrice territoriale confermato generazionalmente, tanto da definire i confini geografici e gustativi di una comunità anche dal gusto della produzione di olio.

Una nuova storia un diverso gusto
Fortunatamente in questi ultimi decenni il mondo dell’olio extravergine di oliva è divenuto protagonista di progresso tecnologico sia della fase estrattiva, sia nelle logiche di coltivazione in campo e questo sta determinando l’evoluzione del gusto e la valorizzazione delle caratteristiche nutraceutiche dell’olio extravergine di oliva. Un processo innovativo che ha riguardato l’intera filiera produttiva: dalle tecniche agronomiche, all’utilizzo di nuovi concetti e tecniche nelle fasi di estrazione, ai nuovi protocolli per la conservazione dell’olio.
Questo movimento di pensiero e di pratiche agronomiche ed estrattive ha trovato terreno fertile e sono nate idee che lentamente si sono consolidate e diffuse in Italia così che esperienza dopo esperienza, sono diventare pensiero prevalente.
Tutto nacque un gruppo di visionari dell’olio sparsi in diversi territori italiani che, ancor prima che Veronelli pubblicasse il suo Manifesto, comincia a riflettere, separatamente all’inizio, collettivamente poi, sulla vera natura dell’oliva e sul corpo di un olio coerente con l’anima profonda dell’olivo. I nostri giovani ricercatori dell’Evo di allora, solo per citarne alcuni, erano: Gianfranco Comincioli, Michele Di Gaetano, Giuseppe Mazzocolin, Antonino Mennella.
Grazie alla loro passione e competenza, intuirono che quel liquido giallo di facile degradazione, poteva e doveva essere qualcosa di molto diverso se il punto di partenza fosse stata un’oliva sana, allevata e raccolta nel giusto tempo: il tempo verde.
Parallelamente al loro pensiero progrediva la tecnologia dell’estrazione e le nuove macchine si affacciavano al mercato con tutta l’incertezza e la precarietà della sperimentazione. Questo non scoraggiò produttori di olio e di apparecchiature per la frangitura, che compresero che si dovevano saldare i loro destini in progetti comuni indirizzati a regalare prodotti dalle mille virtù.
Il processo virtuoso innescato fece emergere la ragione della tradizione, ovvero la certezza che il lavoro tra gli olivi fosse fondamentale per il raggiungimento della qualità. Il frantoio e la tecnologia alleati inscindibili del percorso qualitativo, grazie ad esempio alle temperature di esercizio e ai ridotti tempi di frangitura.
Tutto ciò si può rappresentare come un disegno circolare che ha visto la tecnologia elevare la qualità del lavoro in campo, uno sviluppo che ha portato la pianta e l’oliva ad esprimere finalmente tutte le sue caratteristiche affinché venissero a sua volta valorizzate al meglio in frantoio, in un ciclo di miglioramento dinamico e permanente.
Noi consumatori ed appassionati dell’Evo, siamo i testimoni e i custodi di queste visioni divenute progetti. Con le nostre scelte quotidiane confermiamo la bontà di quelle intuizioni e confermiamo la centralità dell’Olio extravergine di qualità nel nostro sistema alimentare.
Un legittimo interesse individuale che diviene bene collettivo perché, oltre a tutelare la nostra salute, con i nostri comportamenti incidiamo direttamente e concretamente nella conservazione di un ambiente sano. Le ricadute si riverberano sia in ambito produttivo sia sociale per la qualità dei posti di lavoro che si generano. Tutto questo e altro ancora di positivo avviene tramite la scelta di acquisto di una bottiglia offerta tra le tante eccellenze italiane, semplicemente.
In fondo sta in questo la nuova era dell’Evo nella rivoluzione gentile delle nostre scelte.
CHI È MAURIZIO SAGGION
Maurizio Saggion è Coordinatore dell’azione di sistema ProduciAmo Romagna promossa da CNA Rimini. Master universitario in Food and Wine Management, è iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. È sommelier dell’olio; ha il diploma di Sommelier Executive Master of Wine® ed è assaggiatore di formaggio. Ha inoltre il diploma in Master Practitioner in Programmazione Neurolinguistica.